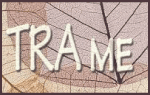La definiscono “rotta balcanica”: è quella che percorrono migliaia di migranti e richiedenti asilo in condizioni disumane. Che posto ha la fraternità in un contesto come quello? Cosa ci insegna la storia di questi Paesi? Nicole Corritore, dell’ “Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa“ ci aiuta a capire…
“I migranti della rotta balcanica”, così la chiamano: migliaia di persone che fuggono da situazioni di guerra, fame, violenza, il più delle volte da morte certa, cercando un modo per entrare nell’Unione Europea. Da alcuni mesi, i media occidentali parlano molto di quello che sta succedendo nel campo profughi di Lipa, al confine tra la Bosnia Erzegovina e la Croazia, dove tanti di loro stanno vivendo in condizioni al limite dell’umano, vivendo all’addiaccio, senza nessun tipo di copertura e protezione, al centro di una situazione geopolitica e diplomatica molto complessa.
Nicole Corritore è una giornalista, lavora da 20 anni presso l’Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa, un centro studi nato nel 2000 – e dal 2004 anche testata online – alla fine della guerra in Kosovo, quando era emersa la necessità di un osservatorio in risposta al bisogno di informazione e dibattito espresso dalla società civile impegnata per l’integrazione dei Balcani nell’Unione Europea. OBC Transeuropa, così come viene chiamato in sintesi, promuove la costruzione dell’Europa dal basso, sviluppando le relazioni transnazionali e sensibilizzando l’opinione pubblica su aree al cuore di numerose sfide europee. Fornisce analisi, informazioni e servizi gratuiti per associazioni, Ong, istituzioni politiche di vari Paesi, su diversi temi tra i quali ambiente, cooperazione diritti umani.
Nicole Corritore, cosa si intende per “rotta balcanica”?
«Bisogna fare un minimo di storia che ci aiuti a comprendere: l’area dei Balcani infatti, per la posizione geografica che occupa, è uno dei principali canali di ingresso via terra per i rifugiati, come dimostrato anche dai dati Eurostat pubblicati lo scorso anno. La maggior parte di loro sono afghani, siriani, iracheni, pakistani, che percorrono la “rotta” perché provengono da Paesi nei quali ci sono pochissime possibilità di uscire per vie legali; i loro passaporti sono infatti molto deboli, è difficile ottenere i visti anche nei casi in cui ci sarebbero tutti i diritti di uscire dal proprio Paese per situazioni di pericolo di vario genere. Pensiamo che queste persone vivono conflitti armati, conflitti sociali, persecuzioni, oppure situazioni in cui non possono assicurarsi una vita dignitosa. L’unica via per loro è salire verso l’Europa, passando per la Turchia per poi continuare verso i Balcani che sono lì vicini, per arrivare nell’Unione. Questo fenomeno migratorio quindi è presente da anni, ma solo adesso se ne parla perché a Lipa si è creata una situazione molto complessa».
Cerchiamo di raccontarla questa situazione, un passo alla volta…
«I migranti puntano a entrare in Europa dopo aver attraversato una serie di Paesi che non sono ancora entrati nell’Unione e che, con le differenze del caso, presentano tutt’oggi problematiche sociali e politiche, come la Macedonia del Nord, la Serbia, il Montenegro, Albania e Bosnia Erzegovina. Tra questi Paesi, forse il più debole, e che ha una grande presenza di richiedenti asilo e di migranti, è proprio la Bosnia.
Qui la situazione è particolarmente grave perché a distanza di 26 anni dalla fine del conflitto è un Paese che si ritrova con una architettura politica complessa, ereditata dagli accordi di Dayton firmati nel Novembre 1995 che ne hanno decretato la divisione. Considerate solo che la Bosnia Erzegovina ha una presidenza tripartita, ha tre presidenti della Repubblica in rappresentanza dei tre popoli costituenti, ed è diviso in due entità: la Federazione croato-musulmana e la Repubblica Srpska. Quindi abbiamo un parlamento nazionale e altri due parlamenti a livello delle entità. La Federazione a sua volta è divisa in 10 cantoni, e poi c’è un territorio speciale, che è il distretto di Brčko. Tutte queste realtà hanno delle autonomie di gestione dei territori, un contesto davvero complesso. In 26 anni, inoltre, il Paese non è riuscito a sollevarsi dalle conseguenze del conflitto, con l’80% delle infrastrutture distrutte e quasi 100mila morti. Su una popolazione di 4.2 milioni di abitanti prima della guerra ha avuto ben 2milioni e 200 mila tra sfollati e rifugiati, e di questi la metà non è mai tornata nei propri territori di origine e nelle proprie case. Il processo di ricostruzione non solo strutturale ma anche sociale ed economico, è stato molto difficile e non ha avuto i risultati che ci si aspettava».
Mi stai dicendo che l’arrivo di altri profughi da altri Paesi ha solo aggravato una situazione di per sé già molto delicata?
«Il flusso di migranti è aumentato nel 2018 in conseguenza soprattutto di due fattori. L’accordo tra Unione Europea e Turchia firmato nel marzo del 2016, con il quale l’UE ha chiesto ad Ankara, in cambio di fondi per l’accoglienza dei rifugiati in Turchia, di controllare il suo confine con la Grecia, il primo Paese dell’Unione che i migranti trovano lungo il loro viaggio. In seguito, sono aumentati i reticolati di filo spinato o veri propri muri ai vari confini con i paesi dell’Unione come Bulgaria, Romania e Austria, che hanno impedito a queste persone di trovare altre vie se non quelle che portano al Cantone di Una Sana in Bosnia prospiciente al confine con la Croazia, dove appunto si trova il campo di Lipa a 30 km dalla città di Bihać».
È per questo che i campi di accoglienza si sono concentrati in quella zona?
«Esatto, in quella zona per loro comincia quello che definiscono il “game”, il “gioco” cioè il tentativo di attraversamento del confine con la Croazia per poi continuare verso altri Paesi. Di fatto quindi dal 2018 la Bosnia Erzegovina si è trovata a gestire un enorme flusso di persone: nel solo 2018 sono stati quasi 24mila, concentrati soprattutto nell’entità della Federazione croato-musulmana, anche perché le autorità dell’altra entità – la Repubblica Srpska – hanno rifiutato di collaborare, impedendo persino il passaggio dei rifugiati sul suo territorio».
A un certo punto si è aggiunta la pandemia….
«Con lo stato di emergenza decretato a marzo 2020 e le relative misure di sicurezza legate al Covid, ai rifugiati è stato impedito l’ingresso nei campi e vietato l’uso di mezzi pubblici per spostarsi sul territorio. Quasi 3mila persone sono rimaste per strada, anche famiglie con bambini, ecco perché ad aprile 2020 è stato aperto il campo di tende di Lipa, soluzione che sarebbe dovuta essere transitoria. Un campo che comunque ospitava, in condizioni già allora non dignitose, 1500 persone, mentre altrettante erano rimaste a vivere negli squat, cioè in case e fabbriche abbandonate o nei boschi attorno alle città di Bihać e Velika Kladusa. Al contempo, se nel 2018 la popolazione era stata eccezionalmente solidale e aveva aiutato per prima i rifugiati, è aumentata l’insofferenza verso la presenza di questi rifugiati nel paese. Sia a causa della malagestione sia per l’alta concentrazione di migranti in un piccolo territorio molto depresso come il Cantone Una Sana, ancora oggi con un alto tasso di disoccupazione e risollevatosi solo in parte dalle conseguenze della guerra degli anni ‘90.
Le autorità locali, sia del cantone sia della municipalità di Bihać, hanno perseguito una politica che ha di fatto rafforzato questa ondata anti-migranti: ha deciso di chiudere il Bira, uno dei campi più grandi in città, e non ha dimostrato alcuna disponibilità di dialogo con le autorità nazionali. Il campo di Lipa non è stato fornito di acqua corrente, elettricità, servizi igienico-sanitari, nonostante le continue richieste di varie organizzazioni internazionali tra le quali L’Organizzazione Mondiale per le Migrazioni (IOM) che ufficialmente gestisce tutti i campi di accoglienza nel Paese. E così, a proposito di Lipa, con l’arrivo dei mesi invernali, le condizioni di vita sono diventate insostenibili e IOM ha deciso il 23 dicembre scorso, di ritirarsi dalla gestione dello stesso. Quello che è accaduto dopo lo avete visto riportato dai media italiani e stranieri».
C’è poi la questione dei respingimenti e quella della violenza della polizia croata di cui si parla spesso. Cosa c’è di vero?
«I respingimenti, chiamati anche “pushback”, vengono purtroppo praticati dalle polizie di numerosi confini da anni. Ma è vero che le violenze maggiori di cui si è a conoscenza sono avvenute in Croazia. Diverse organizzazioni internazionali e locali denunciano da anni queste violenze, con prove e testimonianze alla mano come il Border Monitoring Violence Network: di recente ha pubblicato il “Black book of pushbacks”, due tomi di 1500 pagine che riportano centinaia di testimonianze e il quadro di brutali violenze e persino torture. Ma finora le autorità croate hanno negato la responsabilità diretta delle forze di polizia, indicando come possibili responsabili gruppi indipendenti non legali. Su questo tema, uno degli ultimi tentativi perseguiti da chi si occupa di difesa dei diritti fondamentali dei rifugiati, è quello di Amnesty International che assieme ad altre organizzazioni ha presentato, lo scorso novembre, un’istanza all’Ombudsman europeo (difensore civico). E così l’Ombdusman ha deciso di avviare un’indagine a carico della Commissione Ue chiedendo i motivi del mancato controllo dell’operato della Croazia, quindi eventuali casi di violazione dei diritti umani, e dell’uso che questo paese fa dei fondi europei ricevuti per l’assistenza ai rifugiati e per le operazioni di controllo delle frontiere. Ricordiamo che dal 2017 la Croazia è stata beneficiaria di oltre 108 milioni di euro del Fondo Asilo, migrazione e integrazione e ha ricevuto oltre 23 milioni di euro dei fondi di emergenza destinati all’assistenza».
Come Osservatorio cosa proponete?
«I cambiamenti devono essere fatti a diversi livelli, a partire dalla regolamentazione europea che sostenga un effettivo ricollocamento delle persone che arrivano nei tre primi Paesi di approdo (Spagna, Italia e Grecia) con una distribuzione giusta ed equa in tutti i paesi dell’Unione. Ritengo che si debbano prevedere sanzioni per chi non accetta una gestione solidale del fenomeno migratorio. Le politiche europee di “esternalizzazione”, con le quali si è tenute queste persone ai margini dei confini Ue, oltre che portare a violazioni di diritti fondamentali si sono rivelate un fallimento. Hanno portato a una diminuzione dei flussi, ma hanno reso più difficile e pericoloso il viaggio che queste persone in fuga dai loro paesi intraprendono comunque, perché non hanno alternativa. E al contempo hanno provocato l’aumento “dei prezzi” sul mercato criminale del traffico migratorio che ne ha solo guadagnato. Aumentare e rendere possibili ingressi legali nei Paesi dell’UE, anche temporanei, sarebbe un passo importantissimo, oltre che rafforzare da subito i corridoi umanitari almeno dei casi più vulnerabili come malati, minori non accompagnati e famiglie con figli».
Se ho ben capito serve una sinergia tra Paesi, più solidarietà concreta…
«Serve una politica concordata, l’abbiamo capito anche con la pandemia: fenomeni globali vanno affrontati insieme, non si può fare politica costruendo muri, è nella condivisione dei fenomeni che possiamo trovare delle soluzioni di lungo periodo».
In casi come questo la prospettiva della fratellanza e del “prendersi cura” dei più fragili, diventa utopia?
«Assolutamente no, anzi. La fraternità in questo caso si declina proprio con le questioni politiche. Senza cura, fratellanza e solidarietà, non possiamo pensare di vivere in un mondo come quello che tutti sognano: pacifico, stabile, in cui i diritti fondamentali sono assicurati a tutti, nessuno escluso. In Italia abbiamo visto che senza il sostegno dell’UE non potremmo farcela. Non parlo solo di aiuto economico, ma di solidarietà fattiva, una specie di “rete” dove la politica ha uno sguardo più alto e agisce per il bene di tutti, i più fragili innanzitutto».
Chi le sta particolarmente a cuore in questa situazione?
«I minori non accompagnati, che hanno oltretutto alle spalle già mesi, se non anni, di un viaggio pieno di rischi, violenze e abusi subiti o visti… Solo in Bosnia in questo momento sono circa 500 e diversi vivono nei campi con gli adulti, senza le particolari tutele che la loro età richiede, quindi a rischio di ogni forma di abuso psicologico o fisico. Tra questi oltretutto, come di recente riportato in un rapporto di Save the Children, 50 vivono fuori dai campi, negli squat, o perché ritengono di essere meno a rischio di abusi o perché vogliono proseguire a tentare il “game” attraverso il confine con la Croazia».
Ci si sente impotenti di fronte a tutto questo: è veramente un “gioco” più grande di noi?
«Non lo è se siamo noi a non volerlo. Mi spiego: va cambiato lo sguardo, che non si deve fermare alla finestra di casa nostra. Penso ad Alexander Langer[1], che si è battuto tantissimo nel dialogo tra diversità, per il superamento dei confini, fisici oltre che di “pensiero”. Nel 1994, nel suo “Tentativo di decalogo per la convivenza interetnica”, scriveva che nella nostra società la “convivenza plurietnica, pluriculturale, plurireligiosa, plurilingue, plurinazionale” sarebbe diventata sempre più la normalità e non l’eccezione. Ma che in queste società è importante impegnarsi nel superamento dei confini, “per ammorbidire le rigidità, relativizzare le frontiere, favorire l’integrazione”.
Inoltre parlava di “pacifismo concreto”, cioè di una modalità di impegno pacifico che si basasse su esperienza, pratica, azioni ancorate alla realtà in cui viviamo, e mai scollegato dal lavoro politico insito in queste pratiche. Di fatto, tutti e tutte noi siamo soggetti politici in tutte le nostre scelte quotidiane. Ecco perché credo si debba ricominciare a studiare, comprendere cosa accade attorno a noi e diventare “costruttori di ponti” (altra espressione cara a Langer), cioè persone portatrici della cultura del dialogo e della solidarietà: tra amici, colleghi, vicini di casa, nei negozi che frequentiamo. E questo vale anche per le realtà della società civile: solo se lavoriamo insieme possiamo rafforzare e sostenere cambiamenti di paradigma, e cambiamenti politici, che portino a livello locale, nazionale ed europeo soluzioni a lungo termine per assicurare a queste persone in viaggio i diritti che vengono loro negati».
Fonte: United World Project