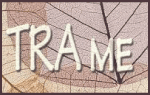Il viaggio disperato lungo la rotta dei Balcani, tra violenze e torture inaudite da parte della polizia Centinaia di profughi con diritto alla protezione respinti dall’Italia
È la schiena curva e livida dei respinti a dire le sprangate. Sono le gambe sanguinanti a raccontare la disperata corsa giù dal valico. A piedi nudi, con le caviglie spezzate dalle bastonate e i cani dell’esercito croato che azzannano gli ultimi della fila. È l’umiliato silenzio di alcuni ragazzi visitati dai medici volontari nel campo bosniaco di Bihac per le cure e il referto: stuprati e seviziati dalla polizia con dei rami raccolti nella boscaglia. I meno sfortunati se la sono cavata con il marchio di una spranga incandescente, a perenne memoria dell’ingresso indesiderato nell’Unione Europea.
Gli orrori avvengono alla luce del sole. Affinché gli altri, i recidivi degli attraversamenti e quelli che dalle retrovie attendono notizie, battano in ritirata. Velika Kladuša e il valico della paura. Di qua è Croazia, Europa. Di la è Bosnia, fuori dalla cortina Ue. Di qua si proclamano i diritti, ma si usa il bastone. Oramai tra i profughi della rotta balcanica lo sanno tutti che con gli agenti sloveni e gli sbirri croati non si scherza.
«Siamo stati consegnati dalla polizia slovena alla polizia croata. Siamo stati picchiati, bastonati, ci hanno tolto le scarpe, preso i soldi e i telefoni. Poi ci hanno spinto fino al confine con la Bosnia, a piedi scalzi. Tanti piangevano per il dolore e per essere stati respinti». Sono le parole di chi aveva finalmente visto i cartelli stradali in italiano, ma è stato rimandato indietro, lungo una filiera del respingimento come non se ne vedeva dalla guerra nella ex Jugoslavia. Certi metodi non sembrano poi cambiati di molto.

Tre Paesi e tre trattamenti. I militari italiani non alzano le mani, ma sono al corrente di cosa accadrà una volta rimandati indietro i migranti intercettati a Trieste come a Gorizia. Più si torna al punto di partenza, e peggio andranno le cose. Le testimonianze consegnate ad Avvenire dai profughi, dalle organizzazioni umanitarie, dai gruppi di avvocati lungo tutta la rotta balcanica, sembrano arrivare da un’altra epoca.
Le foto non mentono. Un uomo si è visto quasi strappare il tendine del ginocchio destro da uno dei mastini delle guardie di confine croate. Quasi tutti hanno il torso attraversato da ematomi, cicatrici, escoriazioni. C’è chi adesso è immobile nella tendopoli di Bihac con la gamba ingessata, chi con il volto completamente bendato, ragazzini con le braccia bloccate dai tutori in attesa che le ossa tornino al loro posto. I segni degli scarponi schiacciati contro la faccia, le costole incrinate, i calci sui genitali. Un ragazzo pachistano mostra una profonda e larga ferita sul naso, il cuoio capelluto malridotto, mentre un infermiere volontario gli pratica le quotidiane medicazioni. Un afghano appena maggiorenne ha l’orecchio destro interamente ricucito con i punti a zigzag. Centinaia raccontano di essere stati allontanati dal suolo italiano.

Una pratica, quella dei respingimenti a ritroso dal confine triestino fino agli accampamenti nel fango della Bosnia, non più episodica. «Solo nei primi otto mesi del 2020 sono state riammesse alla frontiera italo-slovena oltre 900 persone, con una eccezionale impennata nel trimestre estivo, periodo nel quale il fenomeno era già noto al mondo politico che è però rimasto del tutto inerte », lamenta Gianfranco Schiavone, triestino e vicepresidente di Asgi, l’associazione di giuristi specializzati nei diritti umani. «Tra le cittadinanze degli stranieri riammessi in Slovenia il primo posto va agli afghani (811 persone), seguiti da pachistani, iracheni, iraniani, siriani e altre nazionalità, la maggior parte delle quali – precisa Schiavone – relative a Paesi da cui provengono persone con diritto alla protezione ». A ridosso del territorio italiano arriva in realtà solo chi riesce a sfuggire alla caccia all’uomo fino ai tornanti che precedono la prima bandiera tricolore. Per lasciarsi alle spalle quei trecento chilometri da Bihac a Trieste possono volerci due settimane.
Secondo il Danish Refugee Council, che nei Paesi coinvolti ha inviato numerosi osservatori incaricati di raccogliere testimonianze dirette, nel 2019 sono tornate nel solo campo di bosniaco di Bihac 14.444 persone, 1.646 solo nel giugno di quest’anno.
I dati a uso interno del Viminale e visionati da Avvenire confermano l’incremento delle “restituzioni” direttamente alla polizia slovena. Nel secondo semestre del 2019 le riammissioni attive verso Zagabria sono state 107: 39 da Gorizia e 78 da Trieste. Il resto, circa 800 casi, si concentra tutto nel 2020. Il “Border violence monitoring”, una rete che riunisce lungo tutta la dorsale balcanica una dozzina di organizzazioni, tra cui medici legali e avvocati, ha documentato con criteri legali (testimonianze, foto, referti medici) 904 casi di violazione dei diritti umani. Lungo i sentieri sul Carso, tra i cespugli nei fitti boschi in cima ai dirupi, si trovano i tesserini identificativi rilasciati con i timbri dell’Alto commissariato Onu per i rifugiati o dall’Agenzia Onu per le migrazioni. I migranti li abbandonano lì. Testimoniano di come a decine avessero ottenuto la registrazione nei campi allestiti a ridosso del confine balcanico dell’Unione Europea.

Quel documento, che un tempo sarebbe stato considerato un prezioso salvacondotto per invocare poi la protezione internazionale, oggi può essere una condanna. Perché averlo addosso conferma di provenire dalla Bosnia e dunque facilita la “riconsegna” alla polizia slovena. Anche per questo lo chiamano “game”.
Un “gioco” puoi vincere una domanda d’asilo in Italia o in un’altro Paese dell’Ue, o un’altra tornata nell’inferno dei respingimenti. «Quando eravamo nascosti in mezzo ai boschi, la polizia slovena – racconta un altro dei respinti – era anche accompagnata dai cani. Qualcuno si era accucciato nel bosco e non era stato inizialmente visto, ma quattro o cinque cani li hanno scovati e quando hanno provato a scappare sono stati rincorsi dai cani e catturati».
Fonte: Avvenire